Tre.
“L’eroina”
“Si fa di
eroina!”
“Che
significa?” risposi, da innocente qual ero, giacché ancora
un bambino non corrotto dalla vita, a mio cugino, mio omonimo, che aveva
qualche anno più di me e con il quale, spesso, mi trovavo a confrontarmi circa
le dinamiche del territorio in cui vivevamo. Mio cugino, con
quell’esternazione, si riferiva ad Aldo, un ragazzo che come noi abitava nel
quartiere in cui siamo cresciuti e con cui, qualche volta, avevamo anche
giocato. Era da poco arrivato l’inverno, portando con sé tutti i malanni di
quella tormentata stagione. Io, come sempre, ero influenzato, con il moccio
perennemente sul naso che non riuscivo a pulire come avrei dovuto fare. Mia
madre me lo diceva spesso di soffiarmi il naso con i fazzoletti che mi dava, ma
io la ignoravo: punto! Aldo abitava a pochi metri dalla palazzina a due piani
in cui io abitavo allora con la mia famiglia. Aveva dei fratelli, più piccoli,
con i quali, ricordo, egli non andava per niente d’accordo. Forse per via della
roba che si iniettava in vena e che lo rendeva, spesso, una larva umana. Di
Aldo non ricordo molto. Seppi, molti anni più avanti, che egli morì, per colpa
della sua tossicodipendenza, di overdose da eroina un funesto giorno di fine
agosto 1990 a Bologna, città dove si era trasferito con la famiglia. Aveva poco
più che venticinque anni Aldo quando esalò l’ultimo respiro. L’eroina non era solo
la droga che aveva ucciso Aldo, ma quella che andava di moda fra i ragazzi
degli anni Ottanta per sballarsi e distaccarsi dalla realtà che li circondava.
Una droga che, spesso, così come tutte le altre in commercio, facevano perdere
il senso della realtà e il significato vero della vita. La droga per curare il
malessere che tormenta l’anima, dicevano. L’ “Epidemia di morti da droga”,
l’effetto che ne scaturì. Credo che questa fosse solo una frase di circostanza,
detta fuori dai denti da taluni perbenisti solo per minimizzare il reale numero
di perdite di vite umane fra i giovani miei coetanei. Essi cadevano come in una
guerra di trincea, giorno dopo giorno, vittime di un destino a loro beffardo. A
Palermo vi erano delle raffinerie di eroina che erano, a detta di tanti, fra le
più importante del mezzogiorno d’Italia e che riforniva non solo il capoluogo
siciliano, ma anche altre aree geografiche della Sicilia, il continente, e
anche alcune città degli Stati Uniti d’America, New York fra tutte. Palermo era
diventata negli anni Ottanta del Novecento uno dei centri di produzione di
eroina più importanti al mondo. Palermo si era arricchita con l’eroina. Palermo
non era più la stessa città di sempre, ovvero quella città sorniona, spesso
raccontata sui libri di scuola come elitaria per alcuni brevi periodi della sua
storia millenaria, ma una competitor di New York, la città che non dorme mai.
La mafia di allora si arricchì in maniera spropositata, rinvestendo, a detta di
tanti, i capitali frutto del lucroso narcotraffico nell’edilizia speculativa
che portò al cosiddetto “Sacco di Palermo”.
Nel 1982 sarà scoperta una
quarta raffineria a Palermo, in via Messina Marine. Ciascuna di esse produceva
50 kg di eroina a settimana. Da talune inchieste degli anni Sessanta risulta
che la mafia siciliana sarebbe stata “la principale artefice del contrabbando
di stupefacenti diretto dalla mafia statunitense” (Commissione antimafia 1976,
pagina 459). La morfina, che poi veniva raffinata nei laboratori siciliani,
proveniva dalla Turchia e poi dal “triangolo d'oro”, zona montuosa al confine
fra la Tailandia, il Laos e il Myanmar. Salvatore CONTORNO, collaboratore di
giustizia, già fedelissimo di Stefano BONTATE, su questo losco traffico riferì
molti dettagli alla Magistratura inquirente del tempo e in particolare al
Giudice Giovanni FALCONE che ne raccolse per primo le sue dichiarazioni, poi
confluite nel Maxi Processo di Palermo; le dichiarazioni di CONTORNO avrebbero
costituito un’ulteriore conferma a quelle di Tommaso BUSCETTA, consentendo al
Giudice Istruttore di Palermo nel mese di Ottobre dell’Ottantaquattro di
emettere 366 ordini di custodia cautelare: tale blitz passo alla storia come “il blitz di San Michele”. L’operazione
di polizia giudiziaria ebbe vasta eco mediatica, stupendo non solo l’Italia, ma
il mondo intero. Quel giorno circa i due terzi dei soggetti ricercati vennero
tratti in arresto. Di quel periodo ho dei ricordi frammentati. Recentemente ho
rivisto su Youtube[1]
alcune passaggi salienti del Maxi Processo di Palermo[2]
e mi sono documentato su quanto accaduto in quegli anni nefasti anche
attraverso la visione di alcuni film, di nicchia, che oggi è possibile vedere
su alcune piattaforme di streaming.













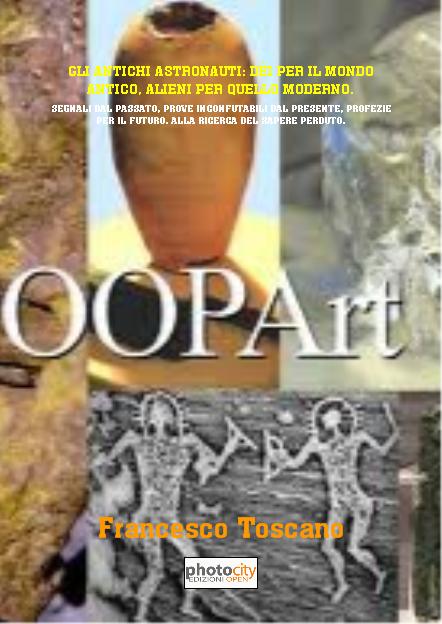
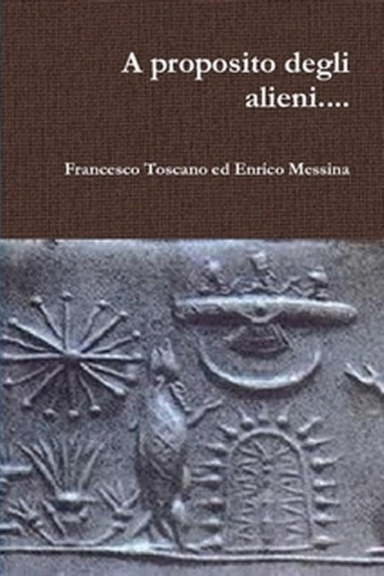
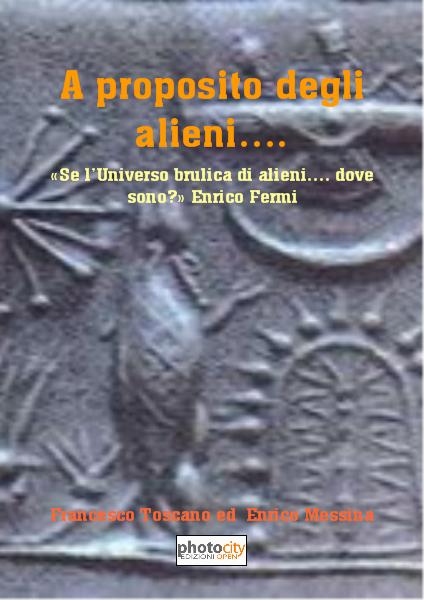
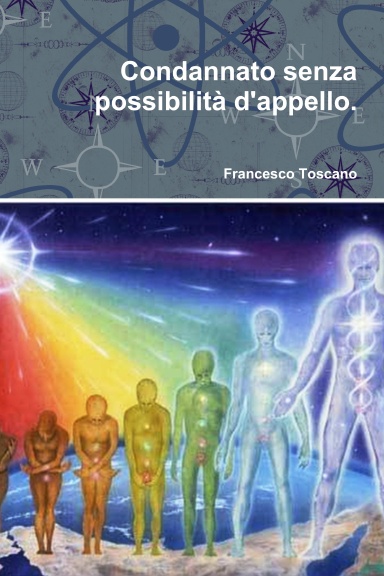
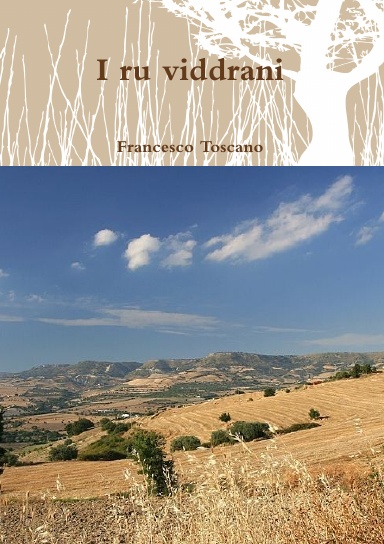
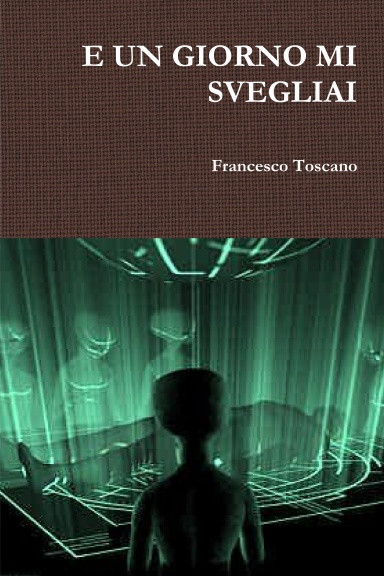

.png)




Il terzo capitolo di "Brancaccino! Ù sai a cu ammazzaru steinnata?"; "Che cosa scrivo adesso?" è intitolato "L'eroina" e affronta il tema del narcotraffico a Palermo negli anni Ottanta. L'autore, Francesco Toscano, racconta la sua prima presa di coscienza sul problema della droga, attraverso un dialogo con suo cugino che gli rivela che un ragazzo del quartiere, di nome Aldo, è diventato un eroinomane.
RispondiEliminaToscano descrive Aldo come un ragazzo problematico, con cui aveva giocato in passato. La droga lo aveva trasformato, rendendolo irriconoscibile. L'autore racconta poi la tragica morte di Aldo, avvenuta per overdose a Bologna nel 1990.
Il capitolo prosegue con una riflessione sul fenomeno dell'eroina a Palermo in quegli anni. Toscano evidenzia come l'eroina fosse diventata la droga più diffusa tra i giovani, un'epidemia che mieteva vittime ogni giorno. La droga era vista come una via di fuga da una realtà difficile, ma spesso conduceva alla morte.
Toscano sottolinea il ruolo della mafia nel traffico di eroina. Palermo, in quegli anni, era diventata uno dei centri di produzione di eroina più importanti al mondo. La mafia, grazie al narcotraffico, si era arricchita in maniera spropositata, reinvestendo i capitali nell'edilizia speculativa che ha portato al "Sacco di Palermo".
Il capitolo si conclude con un accenno al Maxiprocesso di Palermo, il primo grande processo contro Cosa Nostra. Toscano, pur non entrando nel dettaglio, evidenzia come il Maxiprocesso abbia portato alla luce l'enorme potere economico e criminale della mafia, accumulato anche grazie al traffico di droga.
In sintesi, il terzo capitolo di "Che cosa scrivo adesso?" è una cruda e realistica analisi del problema della droga a Palermo negli anni Ottanta. Toscano, attraverso la storia di Aldo, offre un toccante esempio delle conseguenze devastanti dell'eroina. L'autore evidenzia inoltre il ruolo della mafia nel narcotraffico, un fenomeno che ha segnato profondamente la storia di Palermo.