Otto.
“La bambina del balcone difronte”
Fra la via Giacomo ALAGNA, via
Antonio PIGAFETTA, e la via Gino FUNAIOLI insiste un fabbricato di sette piani,
all’ultimo del quale, nel piano attico, vi abitava negli anni Settanta -
Ottanta del secolo scorso una famiglia che ricordo avesse come iniziale del
cognome la lettera “S.”; in quel nucleo familiare vi era anche una bambina che
aveva pressappoco la mia età; ella aveva fratelli e sorelle molto più grandi di
me, che mai conobbi o che frequentai. Penso che il nonno della bambina fosse
stato uno dei costruttori dell’edificio in cui ella abitava. Premetto che io di
questa bambina non seppi mai il nome di battesimo; pur tuttavia, è stato il mio
primo amore, benché solo platonico. Mentre io giocavo per strada la bambina,
dalle lunghe trecce color corvino, mi guardava estasiata dal balcone di casa,
ed io ricambiavo il suo sguardo cercando, come un gallo cedrone, di apparire
quello che non ero. E questa stessa sensazione la ebbi anche quando, già adolescente,
sedicenne, la incontravo giornalmente lungo il viale Amedeo D’Aosta, dopo che
mio padre mi faceva scendere dal suo autoveicolo affinché io raggiungessi, a
piedi, l’I.T.I.S. “A. Volta”. All’epoca dei fatti anche lei era una adolescente,
molto bella, che, purtroppo, aveva deciso di iscriversi e frequentare una altra
scuola cittadina; il nostro rapporto era fatto di sguardi, di sospiri profondi,
desiderandoci l’un l’altra. Ma né io, né lei, avemmo mai il coraggio di
parlarci, di proferire parola, di conoscerci: il nostro amore restò per sempre
solo un amore platonico. Non l’ho più rivista. L’ultima volta che la vidi,
ricordo, ero un giovane diciottenne ed entrambi ci trovavamo a bordo del bus
della linea 24 dell’AMAT, che viaggiava lungo la tratta che da via Messina
Marine, angolo viale Amedeo D’Aosta, avrebbe poi raggiunto la Stazione
Centrale. La sensazione che ebbi allora, e che ancora oggi ho, era che il
destino ci avesse messo difronte solo per farci struggere dentro. Mannaggia a
me e alla mia timidezza. Era destino che non ci saremmo mai dovuti parlare.
Qualcosa limitava le mie azioni e la bambina, divenuta poi un’adolescente, che
oggi spero sia divenuta una donna felice, con figli al seguito, è rimasta solo
un ricordo della mia memoria la quale oggi, dopo essermi concentrato profondamente,
è riuscita a farmi fare un salto pindarico nella mia infanzia.
Nove.
“Acchiana ù patri cu tutti i so’ figghi!”
Quando vassallus ci tagliava la palla di gioco, non ci restava che
sperimentare altri giochi; allora qualcuno di noi proponeva “l’ammucciareddu”,
altri “’na manta e ‘na luna”, altri ancora “pirullè”, ma la
stragrande maggioranza, ovvero quelli che non si stancavano mai di giocare,
proponevano “Acchiana ù patri cu tutti i so’ figghi”. Dopo che il consesso di
bambini aveva deciso a maggioranza, si procedeva oltre. Il più grande tra di
noi formava due squadre: quattro bambini venivano schierati da una parte e gli altri
quattro dall’altra; l’anziano, inoltre, sceglieva i componenti delle due squadre
che avrebbe dovuto formare con attenzione, selezionando i bambini da schierare
tenuto conto sia della loro età, che della loro struttura corporea. La squadra
che iniziava il gioco, la sottomessa o la groppa di “un cavaddu longu longu”, era quella che perdeva nel lancio della
monetina, oppure a seguito del risultato negativo della “cunta”. La squadra perdente era costretta a schierare uno dei suoi
partecipanti, il capitano, all’in piedi e con la schiena appoggiata lungo un solido
muro, mentre gli altri tre componenti della squadra si sarebbero dovuti piegare
a 90 gradi, tenendosi con le mani e con le braccia alle gambe di chi li
precedeva, mentre il bambino all’in piedi avrebbe dovuto sorreggere l’impalcato
formato dalle schiene dei suoi tre compagni di gioco che gli stavano difronte.
La squadra avversaria che aveva vinto nel lancio della monetina, o nella “cunta”, iniziava così il gioco. Il primo
dei suoi giocatori, il capitano, di solito il bambino più grande tra i quattro
componenti della sua squadra, dopo una breve rincorsa sarebbe così salito a
cavalcioni sulla schiena dei bambini che si erano schierati davanti a lui,
proni a 90 gradi, raggiungendo, con non poca difficoltà e facendosi strada sull’impalcato
di schiene venutesi a formare, il petto del bambino che gli stava difronte,
all’in piedi, e che sosteneva i suoi compagni di gioco, più forte che potesse.
Al grido di “Acchiana ù patri cu tutti i
so’ figghi!”, i bambini fantini, o i “figghi
ru patri”, dopo il loro capitano, sarebbero dovuti salire, uno dopo
l’altro, sull’impalcato di schiene formatasi in seguito allo schieramento della
squadra sottomessa, e sino a quando “la
groppa” avrebbe resistito alla “cunta”
recitata da “ù patri chi so’ figghi”,
(ovvero avrebbe dovuto sopportare il peso dei rivali dominanti; quasi sempre la
squadra sottomessa perdeva perché mandava in frantumi l’impalcato di schiene),
ed in particolare: “Quattru e quattru
uottu, scarrica u buottu; l’acieddu cu li pinni, scarrica e vattinni: unu, dui e tri fannu vintitrì, unu dui e tri
fannu vintitrì, ti dugnu un pizzicuni e mi nni vaju” (pizzicotto che
deve darsi per davvero). La squadra avversaria, a sua volta, avrebbe dovuto
rispondere: “abbìriri-chi-mi-ni- vegnu-e-ricu-àschi.”.
Il divertimento “sadico” stava nel fatto che se quelli
che stavano giù, mentre gli altri recitavano la cantilena, sopportavano il peso
di “chiddi” che stanno “‘ncapu” avrebbero vinto la sfida, andando
sopra; se, invece, fossero caduti prima del termine della “cunta” sarebbero rimasti sottomessi, poveri loro. “Acchiana ù patri cu tutti i so’ figghi”
era un gioco all’aria aperta che univa al sano movimento la bellezza della
lingua siciliana, bene da custodire, di cui essere fieri e da insegnare ai
nostri figli. Bei tempi quelli, che ricordo con tanta, tantissima nostalgia.







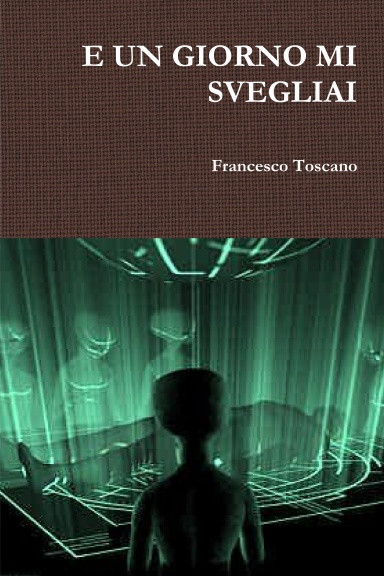










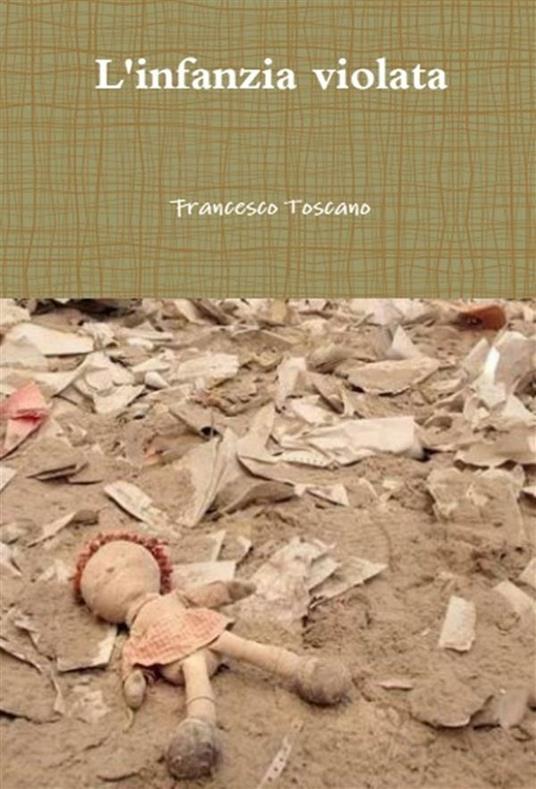


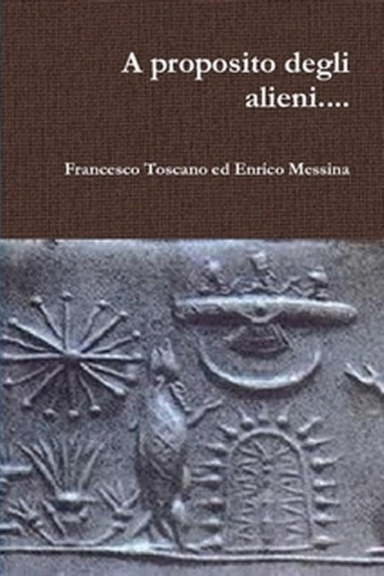

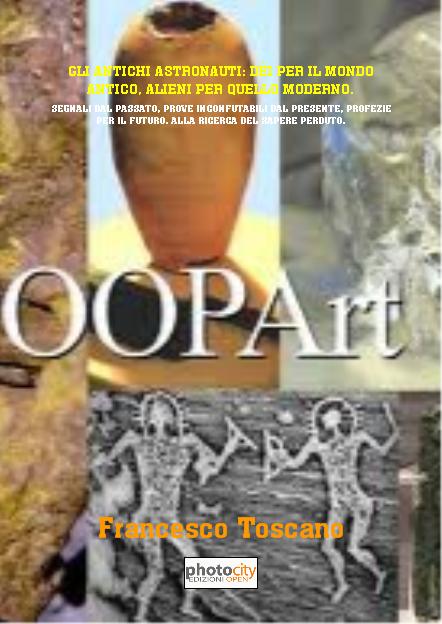




.png)
