I ru viddrani
Uno.
Il sole a quell’ora
del giorno si stagliava alto nel cielo terso del paese natio della zia Pina
Modica e dello zio
Peppino Fiorenza, oramai
avanti negli anni, splendendo fulgidamente come non mai.
Lo avevano avuto un
figlio da crescere i due consorti, pur tuttavia, ma non era stato il loro
bambino, solo il figlio della sorella di lui: il più grande dei suoi tre
nipoti.
Francesco Toscano
Francesco Toscano

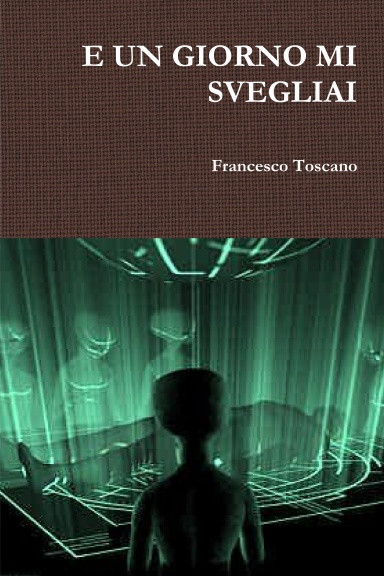











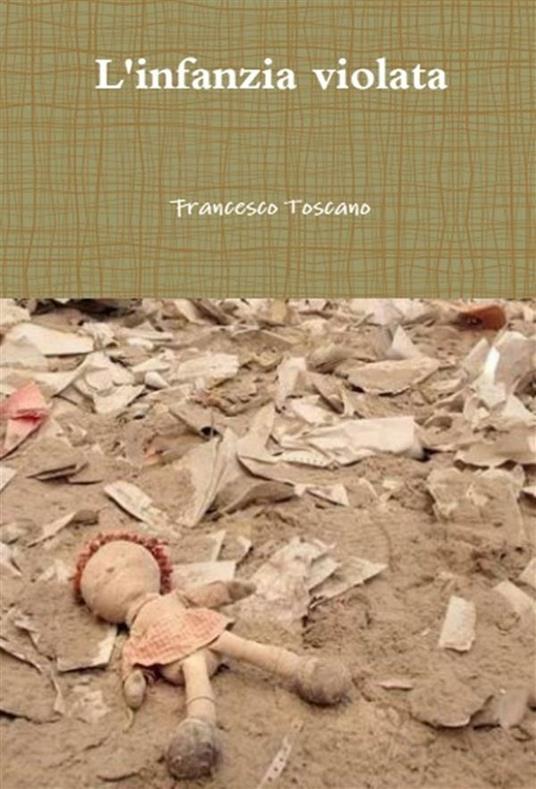


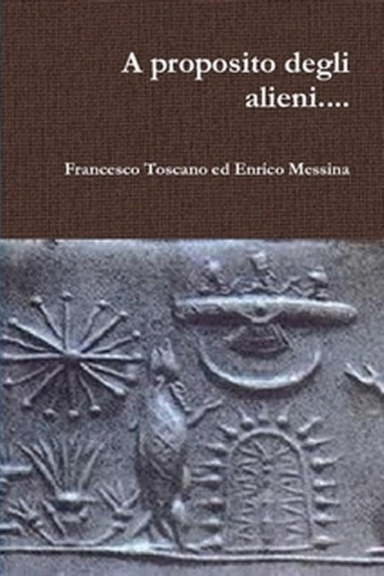

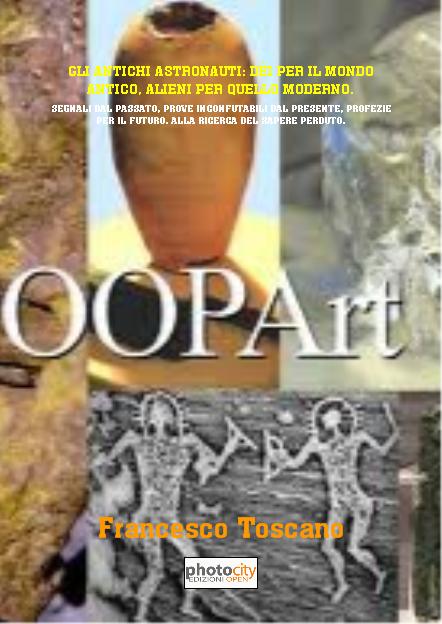




.png)

0 comments:
Posta un commento