" Brancaccino!
Ù sai a cu ammazzaru
steinnata?”
“Che cosa scrivo adesso?”
Di
Francesco Toscano
Premessa.
“Ù
sai a cu ammazzaru steinnata?”;
“Che
cosa scrivo adesso?”
È l’idea, ovvero la domanda, che
più spesso mi è balenata in testa in quest’ultimo periodo di tempo, ma alla
quale non sono stato in grado di dare una risposta esaustiva. Eppure, così come
mi ha detto qualcuno in passato, la fantasia non mi manca e non mi è mai
mancata. Ma adesso non è un problema di fantasia: è un problema di stress
psico-fisico! Per quello, ahimè, non ho, al momento, un rimedio efficace.
Ma, bando alle ciance, vorrei
oggi raccontarvi una storia, una vicenda contraddistinta da mille e più
sfaccettature, che ho da sempre sperato e sognato di scrivere.
È la storia di taluni ragazzi
cresciuti nel quartiere Brancaccio di Palermo, proprio come me.
Un quartiere, quello di
Brancaccio, posto a sud-est del capoluogo siciliano. Uno tra i più popolosi e
popolari, fra l’altro, della mia città natia che è passato alla ribalta della
cronaca nera per omicidi di mafia efferati.
Negli anni Settanta del secolo
scorso, quando ero un bambino, gran parte del quartiere era ricco di
appezzamenti di terreno coltivati ad ortaggi: per lo più cavolfiori e asparagi,
finocchi e patate e, talvolta, anche piantumato con qualche vitigno autoctono e
qualche agrumeto.
Via Giacomo Alagna, l’arteria
stradale dove sono cresciuto, giocando per strada con altri miei coetanei, era
ricca di appezzamenti di terreno coltivati in tal guisa; vi era, ricordo, anche
una fabbrica, dismessa ormai da anni, sorta ai primi del Novecento, per la
distillazione dell’olio di colza: opificio industriale che i vecchi chiamavano
“a fabbrica ò nuzzo (o nuozzo)”.
All’epoca dei fatti, così come lo
è oggi, detta via era delimitata a nord dalla via Messina Marine, mentre a sud
dalla via S. 35, oggi via Padre Giuseppe Puglisi, il prete cattolico ucciso
dalla mafia negli anni Novanta del secolo scorso, il cui appartamento, oggi
adibito a casa museo, era posto a breve distanza da quell’ampio stradone; a
ridosso di questa strada, su cui oggi sfreccia “Genio”, il tram della linea 1 dell’AMAT, sorgeva e sorge la scuola
elementare Nazario Sauro, il circolo didattico da me frequentato da bambino;
essa, poi, era ed è intersecata a sinistra, per chi guarda in direzione del
mare, dalla via F. Sivori ammiraglio, via Pigafetta; via Carlotto, mentre a
destra dalla via Gino Funaioli.
Ma questa non è la storia delle
strade di Palermo o di Palermo, o della toponomastica che contraddistingue il
quartiere Brancaccio, così come non lo è di Brancaccio in senso stretto e della
delinquenza diffusa che lì prosperava e prospera: è la storia di alcuni
bambini, divenuti poi dei ragazzi, ormai degli uomini adulti, con figli e
nipoti al seguito, che lottarono e continuano a lottare per non cadere nelle
maglie dell’illegalità diffusa del quartiere; questa zona geografica di Palermo,
che nell’Ottantadue del Novecento registrò decine e decine di morti ammazzati
per mano di vili mafiosi, che si definivano e tutt’ora si definiscono “uomini
d’onore”, ma il cui comportamento delinquenziale, pur tuttavia, di “onorevole” ha
ben poco, è il proscenio in cui è ambientato questo mio nuovo racconto.
Ci ho riflettuto parecchio,
negli ultimi tempi, e penso che tra i personaggi di cui parlerò non può non
mancare F.M., alias “Franco”,
scomparso a seguito di un tragico incidente stradale lo scorso anno e che io da
bambino ammiravo per la sua tenacia e caparbietà; poi, a seguire, parlerò di S.G.,
alias “Totò”, anch’egli scomparso
qualche anno fa per un carcinoma che lo ha consumato come una candela su cui ardeva
una fiamma splendente, a volte abbacinante, uno dei bambini che come me
frequentavano la scuola elementare Nazario Sauro.
In seguito racconterò della
vicenda umana di V.V., alias “Enzo”,
che, dopo tanti anni di sacrifici, è riuscito ad affermarsi nel campo
dell’infermieristica ed oggi esercita la sua ordinaria attività lavorativa
presso un nosocomio cittadino.
Parlerò di tanti altri abitanti
del quartiere, che ho avuto modo di incontrare in passato e negli ultimi tempi:
un’umanità multi variegata, che lavora, paga le tasse e cerca di affrancarsi sempre
di più da quello stereotipo che contraddistingue il cittadino generico medio residente
nel quartiere che è tristemente legato, a doppia mandata, alla storia degli
ultimi quarant’anni di Palermo.
Il
Quartiere Brancaccio di Palermo: un ritratto complesso.
Il quartiere Brancaccio di
Palermo è un luogo ricco di storia e contraddizioni, profondamente segnato dal
suo passato e in continua evoluzione verso il futuro. Nelle pagine che seguono
si offrirà al lettore uno sguardo multiforme su questo quartiere,
evidenziandone le diverse sfaccettature.
Un
Quartiere popolare e problematico:
Il quartiere è purtroppo noto
per gli efferati omicidi di mafia che vi sono stati commessi, in particolare
negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. La delinquenza diffusa era ed è
ancora una triste realtà a Brancaccio.
Strade
e luoghi significativi:
Via Messina Marine,
un'importante arteria che collega il centro storico di Palermo ai comuni
limitrofi, attraversa il quartiere. Questa strada è sempre congestionata dal
traffico, soprattutto nelle ore di punta. In viale Amedeo D’Aosta, traversa di via
Messina Marine, si trova la scuola elementare Nazario Sauro, frequentata
dall'autore a far data del 1974.
Via Padre Giuseppe Puglisi, già denominata
via S. 35, è intitolata al prete cattolico ucciso dalla mafia il 15 settembre
1993, il giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno a causa del suo impegno
evangelico e sociale; essa è una traversa di viale Amedeo D’Aosta ed è posta a
breve distanza dall’intersezione che viale Amedeo D’Aosta fa col viale dei
Picciotti. All’inizio di viale dei Picciotti, dopo aver percorso pochi metri a
piedi, sulla sinistra e guardando in direzione di via Cappello, si trova Piazzale
Anita Garibaldi; proprio dinanzi al civico contraddistinto col numero 5 del predetto piazzale si trova l'appartamento in cui viveva Padre Pino Puglisi, oggi adibito
a casa museo. Intorno alle 20:40 del 15 settembre 1993 “3P”, ovvero Padre Pino
Puglisi, venne assassinato davanti al portone di casa. Sulla base delle ricostruzioni,
l'assassinio venne condotto con uno stile tipico delle esecuzioni mafiose: don
Pino era arrivato a bordo della sua Fiat Uno di colore bianco e, sceso
dall'automobile, si era avvicinato all'ingresso della sua abitazione, quando
qualcuno lo chiamò e lui si voltò, mentre qualcun altro gli scivolò alle spalle
e gli sparò un colpo di pistola alla nuca, uccidendolo all'istante. I funerali
si svolsero il 17 settembre del 1993.
Il quartiere, sebbene per un
breve tratto, è attraversato dal fiume Oreto, un corso d’acqua a carattere
torrentizio, che sfocia nel Mar Tirreno, la cui foce è visibile dal ponte del
lungomare Sant’Erasmo. Un altro punto di riferimento è lo Stand Florio, anche noto
come "Locanda del tiro a piccione", costruito dalla famiglia Florio,
su progetto di Ernesto Basile, nel 1905.
L'ombra
della Mafia e dell'eroina:
Negli anni Ottanta Palermo, e
quindi anche Brancaccio, è stata colpita da una grave epidemia di morti per
droga, definita da alcuni come una "guerra
di trincea".
La città era diventata uno dei
centri di produzione di eroina più importanti al mondo, rifornendo non solo la
Sicilia, ma anche il continente e gli Stati Uniti.
La mafia ha sfruttato questo
traffico illecito per arricchirsi, trasformando Palermo in una città diversa da
quella del passato.
Brancaccio
nelle opere di Francesco Toscano:
I romanzi di Francesco Toscano,
come "Malacarne", offrono
un'ulteriore prospettiva su Brancaccio, descrivendolo come un luogo segnato
dalla lotta tra il bene e il male e dalla speranza di riscatto.
L'autore, cresciuto a
Brancaccio, utilizza il quartiere come sfondo per le vicende dei suoi
personaggi, riflettendone la violenza endemica e il desiderio di redenzione.
Un
quartiere in trasformazione:
Sebbene le pagine dei libri di
Toscano offrano un quadro a tratti desolante di Brancaccio, è importante
ricordare che il quartiere è in continua evoluzione.
Come ogni luogo, Brancaccio è
abitato da persone che lottano per un futuro migliore, cercando di superare le
difficoltà del passato.
Le iniziative sociali e
culturali, come la casa museo di Padre Puglisi ed altre ancora, rappresentano
un segnale di speranza e un tentativo di riscatto per il quartiere.
Il quartiere è collegato al
centro città per mezzo del tram, la linea 1 dell’AMAT, oltre che dagli autobus
delle linee 224, 226, 237 dell’AMAT.
A ridosso di via Brancaccio,
poi, sorge la stazione ferroviaria di Palermo “Maredolce”, una delle fermate
del passante ferroviario di Palermo che, malgrado sia stata inaugurata in pompa
magna il 16 febbraio 2016, è a tutt’oggi chiusa e risulta non operativa. Dalla
sua attivazione, purtroppo, nessun treno vi ha effettuato mai fermata.
Francesco
Toscano
Uno.
“Il Mundialito”
Franco
era davvero un bel bambino; all’età di quindici anni, ricordo, era il più alto fra
tutti gli altri suoi coetanei, giacché sfiorava il metro e ottanta cm di
altezza. Franco era tenace, caparbio, estroverso, giocoso, pieno di vita,
solare; ma la vita, purtroppo, dopo avergli voltato le spalle in maniera
beffarda, lo avrebbe abbandonato definitivamente sulla soglia dei Sessant’anni,
in seguito ad un tragico incidente stradale sulla circonvallazione di Palermo,
nei pressi del quartiere Bonagia. Ma questo Franco non lo sapeva allora. Perché
lo avrebbe dovuto sapere? Chi mai glielo avrebbe potuto riferire che la sua
vita sarebbe terminata tragicamente, quando ancora era un adolescente allegro e
pieno di vita? Un giorno, egli decise, sulla scia del fenomeno “Mundialito”[1],
che era andato in onda in Tv a quel tempo, di organizzare un torneo di calcio
per i bambini che abitavano a ridosso dell’intersezione viaria esistente tra la
via G. Alagna e la via G. Funaioli. A quel tempo, all’incrocio tra via G.
Alagna con la via G. Funaioli era presente un pezzo di strada, asfaltata dal
Municipio, che terminava su di un appezzamento di terreno, coltivato ad
ortaggi, penso che fossero dei cavolfiori, di proprietà di un tale a nome V.,
alias vassallus, oggi deceduto, che,
bontà sua, era solito bucare i palloni in cuoio utilizzati dai bambini che
abitavano a breve distanza da quell’appezzamento di terreno; che cercavano, in
barba a tutti, di sfidarsi nelle varie partite di un torneo di calcio che
sarebbe stato da loro giocato su di quella angusta arteria stradale, da poco resa
fruibile dall’asfalto nero di catrame ivi posatovi, bruciata dal sole d’estate di
un torrido anno 1981. La sorte, ahinoi, aveva voluto che arrivassero
all’interno dell’appezzamento di terreno, chiuso e delimitato da lamiera
zincata, coltivato dal vassallus e che
questi amorevolmente zappava con tanta fatica, i nostri numerosi palloni,
inizialmente dei “Super Santos” e, infine, alcuni in cuoio con camera d’aria.
Ma all’epoca dei fatti né io, né gli altri bambini eravamo in grado di capire
perché l’ira si impossessava della mente di quell’uomo ogni qualvolta una palla
cadeva all’interno del suo appezzamento di terreno. L’unica cosa che capivamo
era che un vecchio, a nostro parere stolido, era solito tagliarci la palla da
gioco che con tanti sacrifici i nostri genitori avevano comperato affinché noi ci
potessimo divertire. Fischietto in bocca, Franco dirigeva tutti gli incontri di
calcio, che sarebbero poi stati combattuti da noi bambini come dei provetti
campioni, poi vinti, ricordo il più delle volte, dai nostri spietati avversari:
dei bambini abitanti a qualche chilometro di distanza da quella via, che, più
di noi, erano davvero bravi a giocare a calcio. Fra tutti, io, ero il più
piccolo. Un mio cugino, mio omonimo e che oggi vive al Nord Italia, decise per
me che io dovessi difendere la nostra porta, i cui pali, inesistenti, erano
fatti dalla prima cosa raccolta per strada che potesse rimanere al suolo e non
volar via con la prima folata di vento. Il torneo del nostro “Mundialito”, per ovvi motivi, durò ben
poco. Non eravamo in grado di acquistare un pallone al giorno; nessuno di noi
lavorava, né i nostri genitori, per lo più operai, erano disposti a spendere i
loro averi per acquistare dei palloni di calcio che, in poco tempo, qualcuno
avrebbe distrutto e a cui non gli si poteva dire nulla, se non “mi scusi, ma i bambini dove devono giocare?”.
A tale domanda, seppure legittima, non seguì mai alcuna risposta da parte
dell’anziano contadino che, stanco di dover contrastare con un nugolo di
marmocchi e con i loro familiari, si era, a suo dire, “sfastidiatu” per così tanta tracotanza da parte di quei giovani
genitori che, invece di tenersi a casa i figli, prediligevano che quei
marmocchi giocassero per strada con quei orribili palloni di cuoio, pesanti,
che colpendo i suoi ortaggi, frutto di sacrifici e sudore, li distruggevano definitivamente.
I bambini, pur tuttavia, non curanti di quanto fosse accaduto loro, qualche
giorno dopo ripresero a giocare quelle partite di calcio che avevano lasciato
in sospeso. Il torneo, a cui seguirono dei festeggiamenti con tanto di medaglie
per i partecipanti e coppa per la squadra vincitrice, si concluse a ridosso del
giorno di Natale dell’Ottantuno. Franco ci teneva a che il torneo arrivasse
alla fine, non perché si volesse mettere in mostra come arbitro ai nostri occhi
da bambini viziati e spensierati, ma perché, in cuor suo, desiderava di poterci
dare un futuro diverso e tenerci lontani da quei giovanotti che, come se
fossero delle nuove maghe Circe pronti ad ammaliare, attiravano gli adolescenti
del quartiere verso il mondo della droga e dello spaccio di eroina. Era il suo
primo torneo da arbitro ufficiale. Qualche anno dopo, ricordo, egli mi disse
che si era iscritto alla delegazione cittadina della federazione italiana
giuoco calcio; era orgoglioso di quanto stava per accadergli. Mi disse che così
avrebbe potuto arbitrare delle partite di calcio che contavano per davvero,
benché si fossero disputate in quei campi di periferia in cui, purtroppo, i
genitori litigano tra loro e con il mister pensando che il figlio, ai loro
occhi già campione provetto, non meriti di starsene in panchina. Di quei giorni
in cui, madido di sudore, mi ritiravo a casa stremato per aver dato tutto me
stesso in quel campo di calcio provvisorio, fatto di sangue e catrame, per via
dei numerosi incidenti di giuoco, ho un vivido ricordo. Me ne ero dimenticato
in tutti questi anni. È bastato leggere su internet della tragedia che ha
colpito il mio amico d’infanzia e la sua famiglia che tutto, come se di colpo avessi
riavvolto il nastro della mia memoria, benché racchiuso all’interno di un
cofanetto di cellule nervose, (così come quei vecchi film in otto millimetri che
erano racchiusi in cofanetti di metallo), mi si è palesato davanti agli occhi
il ricordo di quei giorni felici, come
se fossi stato nuovamente proiettato in quella realtà dell’essere, attraverso
un cunicolo gravitazionale o Einstein - Rosen.
Per difendere dignitosamente la
porta della mia squadra, pur tuttavia, mi sarei dovuto impegnare oltremodo,
anche tenuto conto del fatto che ero davvero piccolo e, per connotazione
genetica, non molto alto; i miei sforzi si sarebbero dovuti concentrare nel
difendere la porta longitudinalmente, in lunghezza, avuto riguardo del fatto
che la porta non avesse né pali, né traversa. Allora, instancabilmente,
qualcuno, uno dei miei cugini di solito, mi allenava all’interno dell’area
garage del condominio posto all’intersezione tra le vie G. Alagna e G. Funaioli,
ove i miei zii avevano due box di proprietà. Chissà quante volte i condomini di
quel palazzo ci mandarono a quel paese, dissero di noi peste e corna, per tutti
quei rumori molesti che noi facevamo all’interno del residence in cui essi
vivevano; non ricordo, pur tuttavia, che qualcuno si lamentò con noi o che
qualcuno avesse mai inveito contro di noi: ritengo che le nostre mamme fossero davvero
felici di sapere che noi tutti fossimo rinchiusi all’interno di un’area in cui
nessuno ci avrebbe potuto molestare, infastidire, approfittarsi della nostra
giovane età e farci commettere delle azioni contro norma. Tantissime volte
rischiai di rompermi una gamba; a volte rincasavo con un nuovo livido in corpo,
con un nuovo taglio alle braccia o alle gambe, poiché per prendere quella maledetta
palla che mi tiravano letteralmente addosso, non potendomi scansare e dovendo
assurgere a ultimo baluardo di difesa, ero costretto a fare le capriole, come
se fossi stato una scimmietta ammaestrata da un circense. Ad un certo punto non
li contai più i lividi, né, tantomeno, mia madre ci fece più caso. La mia
giovane età mi consentiva di recuperare in fretta, e il mio corpo riparava in
fretta tagli e ferite che mi ero procurato o che altri mi avevano regalato,
bontà loro. Una cicatrice, però, quella ce l’ho ancora. Un giorno, mentre
giocavo con la mia bici, che mio padre e mia madre mi avevano regalato per il Natale
del 1975, percorrendo la via Antonio Pigafetta, esattamente in prossimità della
discesa che portava al garage del servizio Pullman della ditta Pecoraro, un
bambino, con cui sovente giocavo, mi spinse repentinamente e talmente così
forte lungo quella discesa che io non ebbi il tempo di frenare la bici, così
sbattendo la faccia nel cancello in ferro che chiudeva lo scantinato. I tre
punti di sutura che mi diedero al labbro inferiore al Pronto Soccorso
dell’Ospedale Buccheri La Ferla, a sangue caldo, li ho ricontati oggi tutti e
tre, drammaticamente, rivivendo quel momento poco felice da me vissuto in
giovane età. Qualche giorno fa, passeggiando col cane di mia figlia in via G.
Funaioli, mi sono fermato proprio in prossimità di quell’area condominiale dove
giocavo da bambino, dovendo il cagnolino fare i suoi bisogni; lì mi sono reso
conto di quanto fossimo stati imprudenti da bambini. Ho guardato quell’area condominiale
con molta attenzione: una Stradella d’ingresso davvero piccola, che consente
l’accesso di un solo autoveicolo per volta, meglio se si tratti di una berlina,
perché già un SUV, quelli che oggi sfrecciano lungo le strade cittadine,
avrebbe non poche difficoltà ad entrarvi agevolmente. Le piastrelle con cui è
lastricato il viale di accesso all’area garage di quel fabbricato, di colore
rosa, le ho riguardate con attenzione e, attraverso una serie di flashback, mi
sono rivisto più volte per terra, dolorante, con il volto schiacciato su di una
di esse. Malgrado tutto esse, inesorabilmente, hanno resistito al tempo
trascorso, mostrandosi alla mia vista così come io me li ricordavo.

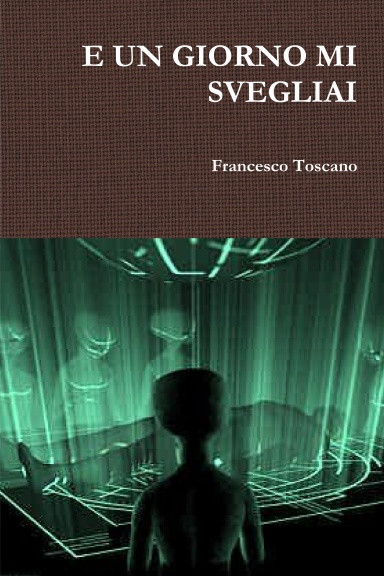












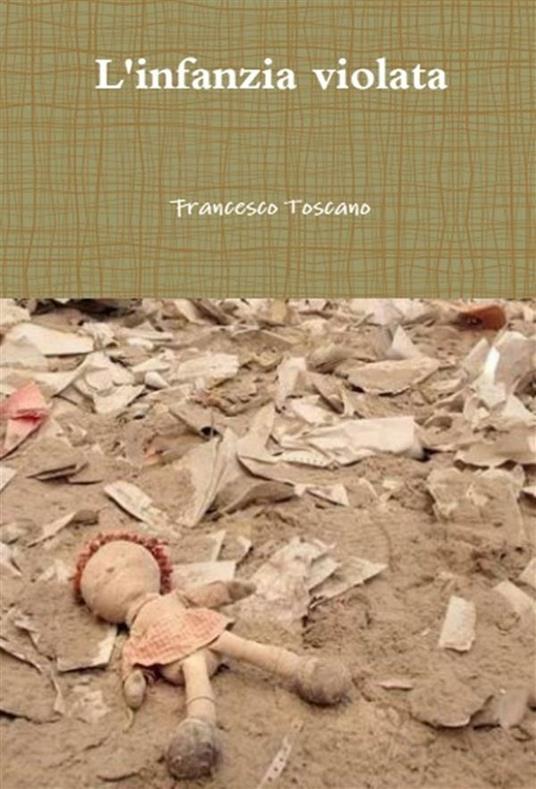


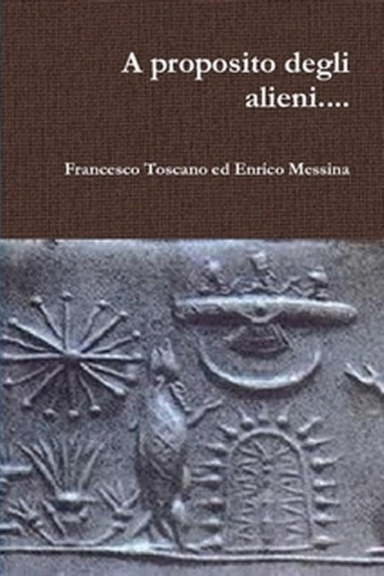

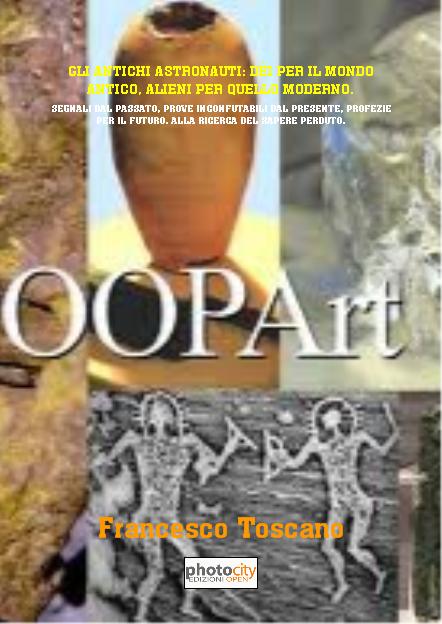




.png)

Il tema principale di “Brancaccino! Ù sai a cu ammazzaru steinnata?"; "Che cosa scrivo adesso?" è l'esperienza di vita dell'autore, Francesco Toscano, nel quartiere Brancaccio di Palermo tra la fine degli anni Settanta e Ottanta. L'opera è una narrazione autobiografica suddivisa in capitoli che ripercorrono la sua vita dalla fanciullezza alla maggiore età.
RispondiEliminaBrancaccio diventa lo scenario principale in cui si svolgono le vicende umane dei personaggi. Toscano descrive un'infanzia segnata dalla violenza endemica del quartiere, offrendo uno spaccato sulla società siciliana di quegli anni. La narrazione si focalizza anche sulla lotta tra il bene e il male e la speranza di redenzione. Il libro affronta temi importanti come:
• la mafia;
• la droga;
• la violenza;
• il bullismo.
L'autore utilizza lo pseudonimo per i personaggi, e il dialetto siciliano arricchisce la narrazione rendendola più autentica.
Francesco Toscano descrive Brancaccio come un quartiere di Palermo segnato dalla violenza endemica, dalla lotta tra il bene e il male e dalla speranza di riscatto. L'autore, cresciuto a Brancaccio, utilizza il quartiere come sfondo per le vicende dei suoi personaggi, riflettendo la realtà di quegli anni.
RispondiEliminaNei suoi romanzi, come "Malacarne", Toscano descrive Brancaccio come un luogo difficile, segnato dalla presenza della mafia e del traffico di droga. Tuttavia, sottolinea anche la presenza di persone oneste che lottano per un futuro migliore.
Nonostante il quadro a tratti desolante offerto dai suoi libri, Toscano ricorda che Brancaccio è in continua evoluzione. Iniziative sociali e culturali, come la casa museo di Padre Puglisi, rappresentano un segnale di speranza e un tentativo di riscatto per il quartiere.
Ecco alcuni punti chiave sulla condizione di Brancaccio secondo Toscano:
• Violenza endemica: la mafia e il traffico di droga hanno segnato profondamente il quartiere.
• Lotta tra il bene e il male: la presenza di persone oneste che si oppongono alla criminalità.
• Speranza di riscatto: le iniziative sociali e culturali offrono un barlume di speranza per un futuro migliore.
• Quartiere in trasformazione: Brancaccio è in continua evoluzione e la speranza è che le cose cambino in meglio.
In definitiva, Toscano presenta Brancaccio come un microcosmo della condizione umana, dove la bellezza si scontra con il degrado e la speranza di riscatto si scontra con la violenza.
La premessa e il primo capitolo di "Brancaccino! Ù sai a cu ammazzaru steinnata?”; "Che cosa scrivo adesso?", di Francesco Toscano, offrono un'introduzione intrigante al mondo dell'autore e al contesto del suo racconto.
RispondiEliminaPremessa:
• L'autore, Francesco Toscano, esprime la difficoltà di trovare un'idea per la sua prossima opera. La domanda "Che cosa scrivo adesso?" lo tormenta, nonostante la sua immaginazione.
• Toscano attribuisce questo blocco creativo allo stress psico-fisico, per il quale non ha ancora trovato un rimedio efficace.
Capitolo Uno:
Il titolo del capitolo, " Il Mundialito", introduce immediatamente il lettore al tema centrale del racconto: un'esperienza infantile dell'autore nel quartiere Brancaccio di Palermo.
• Il capitolo descrive una tipica giornata di gioco per strada con gli amici, un'attività comune per i bambini del quartiere negli anni Settanta-Ottanta.
• Il dialetto siciliano è presente fin dalle prime frasi del capitolo.
• La partita di pallone è descritta con dettagli vivaci, come la porta improvvisata con ciò che i bambini trovavano per strada e che non volasse via con le prime folate di vento.
• La frase " Ù sai a cu ammazzaru steinnata? ", pronunciata da un adulto, introduce il tema della violenza e della mafia nel racconto.
• L'innocenza dei bambini contrasta con la realtà brutale che li circonda, rappresentata dalla frase "ammazzaru ".
• Il capitolo si conclude con un senso di mistero e di inquietudine, lasciando il lettore desideroso di scoprire cosa succederà dopo.
Considerazioni generali:
• Brancaccio è più di un semplice sfondo: è un personaggio a sé stante, con la sua atmosfera unica e le sue dinamiche sociali.
• La narrazione è realistica e coinvolgente, grazie all'uso del dialetto, dei dettagli sensoriali e della descrizione accurata dei giochi infantili.
• L'autore non idealizza il passato, ma presenta un quadro autentico del quartiere, con le sue luci e le sue ombre.
• La violenza è presente, ma non è l'unico tema del racconto. Toscano esplora anche l'innocenza, l'amicizia e la vita quotidiana dei bambini.
• La premessa e il primo capitolo stabiliscono un tono introspettivo e nostalgico, preparando il lettore a un viaggio emozionante nel passato dell'autore.