 II periodo tra la fine dell'XI e la fine del XII secolo è per Palermo un momento particolarmente felice. Dal punto di vista artistico, la Sicilia raggiunge in quei secoli livelli mai più eguagliati. Non è facile definire in poche righe - le discussioni sull'argomento sono ancora, per alcuni versi, aperte - l'arte palermitana di quei secoli: cercheremo di dare qui di seguito alcuni spunti che potranno essere ampliati con l'aiuto della vastissima bibliografia esistente in materia. La conquista della Sicilia da parte dei Normanni - essi entrarono in Palermo nel 1072 - segnò la fine della dominazione araba nell'isola, durata fin dall'827. I Normanni erano uno sparuto gruppo di guerrieri, i quali si trovarono di fronte ad una fiorentissima civiltà, con caratteri preponderanti arabi, e che conservava con fedeltà anche caratteri latini e greci. L'intelligenza dei sovrani normanni, da Ruggero il Gran Conte a Guglielmo II, per non dimenticare l'ultimo erede di quella tradizione, l'imperatore Federico II, fece sì che in Sicilia - ed a Palermo in particolare - tutto quello che di buono quelle secolari civiltà avevano prodotto e tramandato, fosse mantenuto e valorizzato. Ruggero II,
II periodo tra la fine dell'XI e la fine del XII secolo è per Palermo un momento particolarmente felice. Dal punto di vista artistico, la Sicilia raggiunge in quei secoli livelli mai più eguagliati. Non è facile definire in poche righe - le discussioni sull'argomento sono ancora, per alcuni versi, aperte - l'arte palermitana di quei secoli: cercheremo di dare qui di seguito alcuni spunti che potranno essere ampliati con l'aiuto della vastissima bibliografia esistente in materia. La conquista della Sicilia da parte dei Normanni - essi entrarono in Palermo nel 1072 - segnò la fine della dominazione araba nell'isola, durata fin dall'827. I Normanni erano uno sparuto gruppo di guerrieri, i quali si trovarono di fronte ad una fiorentissima civiltà, con caratteri preponderanti arabi, e che conservava con fedeltà anche caratteri latini e greci. L'intelligenza dei sovrani normanni, da Ruggero il Gran Conte a Guglielmo II, per non dimenticare l'ultimo erede di quella tradizione, l'imperatore Federico II, fece sì che in Sicilia - ed a Palermo in particolare - tutto quello che di buono quelle secolari civiltà avevano prodotto e tramandato, fosse mantenuto e valorizzato. Ruggero II,  il primo grande monarca normanno, si trovò signore di un popolo estremamente diverso nelle sue componenti: arabi, greci, ebrei, siciliani di origine latina, e ne mise a profitto le energie così varie, dopo aver compreso che solo puntando su quelle forze e su quella gente avrebbe potuto fondare un solido regno. Artisti, geografi, poeti, latini, greci ed arabi affollarono la corte del grande re. Le testimonianze culturali, religiose, architettoniche, iconografiche del confluire e del fruttificare di queste forze indigene sono notevoli in quel periodo a Palermo.
il primo grande monarca normanno, si trovò signore di un popolo estremamente diverso nelle sue componenti: arabi, greci, ebrei, siciliani di origine latina, e ne mise a profitto le energie così varie, dopo aver compreso che solo puntando su quelle forze e su quella gente avrebbe potuto fondare un solido regno. Artisti, geografi, poeti, latini, greci ed arabi affollarono la corte del grande re. Le testimonianze culturali, religiose, architettoniche, iconografiche del confluire e del fruttificare di queste forze indigene sono notevoli in quel periodo a Palermo.  Ma al seguito dei Normanni erano venuti in Sicilia anche dei monaci benedettini, cui Ruggero darà compiti di notevole importanza nella costituzione delle nuove diocesi di rito latino. Ruggero II, infatti, aveva instaurato con il Papato un particolarissimo tipo di rapporto, del quale l' "Apostolica Legatìa" è il segno più importante. Incomincia infatti in questo periodo la creazione da parte del re di numerosi conventi e vescovati di rito latino - quasi in omaggio alla volontà del Papa -mentre però a quei monasteri altrettanti se ne affiancavano di rito greco, largamente autonomi, per controbilanciare il prepotere latino. Nacque così una nuova cultura, una nuova arte, ed in particolare una nuova architettura, che fu il risultato di un miscuglio di componenti assai varie, che raggiunse talvolta un alto grado di sintesi.
Ma al seguito dei Normanni erano venuti in Sicilia anche dei monaci benedettini, cui Ruggero darà compiti di notevole importanza nella costituzione delle nuove diocesi di rito latino. Ruggero II, infatti, aveva instaurato con il Papato un particolarissimo tipo di rapporto, del quale l' "Apostolica Legatìa" è il segno più importante. Incomincia infatti in questo periodo la creazione da parte del re di numerosi conventi e vescovati di rito latino - quasi in omaggio alla volontà del Papa -mentre però a quei monasteri altrettanti se ne affiancavano di rito greco, largamente autonomi, per controbilanciare il prepotere latino. Nacque così una nuova cultura, una nuova arte, ed in particolare una nuova architettura, che fu il risultato di un miscuglio di componenti assai varie, che raggiunse talvolta un alto grado di sintesi.- latini, negli impianti basilicali delle chiese;
- bizantini, nei ricchi manti musivi;
- nord-africani, nelle cupole, nelle fontane, negli archi e nei paramenti murari. I primi monumenti dell'epoca normanna, e particolarmente quelli costruiti sotto i due Ruggeri: S. Giovanni dei Lebbrosi, S. Giovanni degli Eremiti, la Reale Cappella di S. Pietro (Cappella Palatina), sono il prodotto di una antichissima tradizione che ha la sua culla nell'Africa del Nord. Se osserviamo questi edifici, per quanto riguarda gli esterni essi presentano piani contrapposti e distinti da ricorrenti cornici angolari, mentre gli interni sono spazi sostanzialmente cubici, variamente adattati.
 Mentre gli esterni vengono animati da lineassi archiacuti intagliati, ciechi o attorno alle finestre, gli interni vengono suddivisi da colonnati collegati da archi acuti rialzati e coronati da cupole ad alto tamburo, raccordate in vario modo (nicchie, etc.) al quadrato di base.Tutti questi edifici sono di dimensioni contenute e mostrano una proporzione armoniosa tra volumi e spazi, mentre nel periodo successivo tenderanno al grandioso (vedi le grandi cattedrali di Monreale e di Palermo).
Mentre gli esterni vengono animati da lineassi archiacuti intagliati, ciechi o attorno alle finestre, gli interni vengono suddivisi da colonnati collegati da archi acuti rialzati e coronati da cupole ad alto tamburo, raccordate in vario modo (nicchie, etc.) al quadrato di base.Tutti questi edifici sono di dimensioni contenute e mostrano una proporzione armoniosa tra volumi e spazi, mentre nel periodo successivo tenderanno al grandioso (vedi le grandi cattedrali di Monreale e di Palermo).
 Accanto a questi influssi resistono però vigorosamente quelli orientali e soprattutto bizantini, come notiamo per esempio, nell'impostazione interna di S. Maria dell'Ammiraglio, la cui pianta è a croce inscritta con la caratteristica cupoletta di coronamento e possiede un ricco paramento musivo.A Palermo poi gli influssi tradizionali citati vengono arricchiti da motivi nordici, quali i gruppi di colonne di sostegno, le gallerie a colonnati, le torri tipiche dei templi franco-inglesi, mentre il gusto per la policromia, che si evidenzia negli archetti intrecciati, risente dell'influsso campano. Già Ruggero II aveva chiamato, per la sua cattedrale di Cefalù, artisti lombardi ed anglo-francesi. La Chiesa della SS. Trinità (Magione), che appartiene alla seconda metà del secolo XII, unisce la monocromia esterna allo slancio verso l'alto. Nella basilica di S. Spirito vengono introdotti nuovi motivi, soprattutto quelli benedettini: pilastri cilindrici, formati da rozzi blocchi e decorazione esterna già orientata verso nuovi gusti, mentre scompaiono le cupole di copertura e si afferma definitivamente la pianta basilicale.
Accanto a questi influssi resistono però vigorosamente quelli orientali e soprattutto bizantini, come notiamo per esempio, nell'impostazione interna di S. Maria dell'Ammiraglio, la cui pianta è a croce inscritta con la caratteristica cupoletta di coronamento e possiede un ricco paramento musivo.A Palermo poi gli influssi tradizionali citati vengono arricchiti da motivi nordici, quali i gruppi di colonne di sostegno, le gallerie a colonnati, le torri tipiche dei templi franco-inglesi, mentre il gusto per la policromia, che si evidenzia negli archetti intrecciati, risente dell'influsso campano. Già Ruggero II aveva chiamato, per la sua cattedrale di Cefalù, artisti lombardi ed anglo-francesi. La Chiesa della SS. Trinità (Magione), che appartiene alla seconda metà del secolo XII, unisce la monocromia esterna allo slancio verso l'alto. Nella basilica di S. Spirito vengono introdotti nuovi motivi, soprattutto quelli benedettini: pilastri cilindrici, formati da rozzi blocchi e decorazione esterna già orientata verso nuovi gusti, mentre scompaiono le cupole di copertura e si afferma definitivamente la pianta basilicale.  Così gli influssi provenzali (vedi cariatidi nel sarcofago di Ruggero II) e campani (cero pasquale della Reale Cappella di S. Pietro) convivono con le componenti arabe, bizantine e benedettine. Per quanto riguarda i mosaici, di squisita fattura sono quelli di S. Maria dell'Ammiraglio - di ispirazione bizantina - mentre raggiungono un alto grado di perfezione nella Reale Cappella di S. Pietro, dove, celebrando i fasti del re, si arricchiscono di una forte nota di arabismo. Un discorso a parte meriterebbe il soffitto arabo a stalattiti della Cappella Palatina, decorato con figure profane, accostato al ciclo apocalittico della cupola, a quello cristologico ed apostolico del transetto e delle navate. Il regno di Enrico VI Hohenstaufen (1194-1197) interruppe tutto questo fervore architettonico che,per quanto riguarda Palermo, non conobbe riprese neanche sotto Federico II (1197-1250) anche se in questa parte del secolo XIII vi fu in Palermo una grande attività edilizia del tipo civile ed una conseguente, notevole espansione urbanistica.
Così gli influssi provenzali (vedi cariatidi nel sarcofago di Ruggero II) e campani (cero pasquale della Reale Cappella di S. Pietro) convivono con le componenti arabe, bizantine e benedettine. Per quanto riguarda i mosaici, di squisita fattura sono quelli di S. Maria dell'Ammiraglio - di ispirazione bizantina - mentre raggiungono un alto grado di perfezione nella Reale Cappella di S. Pietro, dove, celebrando i fasti del re, si arricchiscono di una forte nota di arabismo. Un discorso a parte meriterebbe il soffitto arabo a stalattiti della Cappella Palatina, decorato con figure profane, accostato al ciclo apocalittico della cupola, a quello cristologico ed apostolico del transetto e delle navate. Il regno di Enrico VI Hohenstaufen (1194-1197) interruppe tutto questo fervore architettonico che,per quanto riguarda Palermo, non conobbe riprese neanche sotto Federico II (1197-1250) anche se in questa parte del secolo XIII vi fu in Palermo una grande attività edilizia del tipo civile ed una conseguente, notevole espansione urbanistica.Bigliografia: Dai Momumenti alla storia - Itinerari didattici attraverso Palermo Medioevale, di G. Di Simone, Zelmira Marazio Schiera, Zito Arti Grafiche - Palermo 1995. Pagina 139,140.












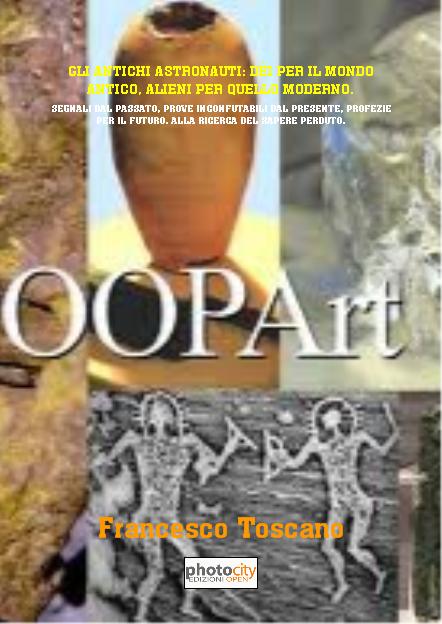
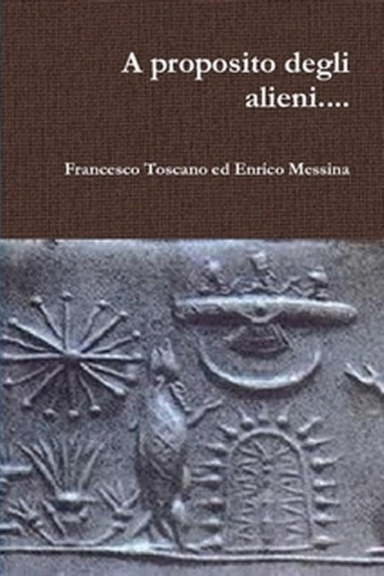
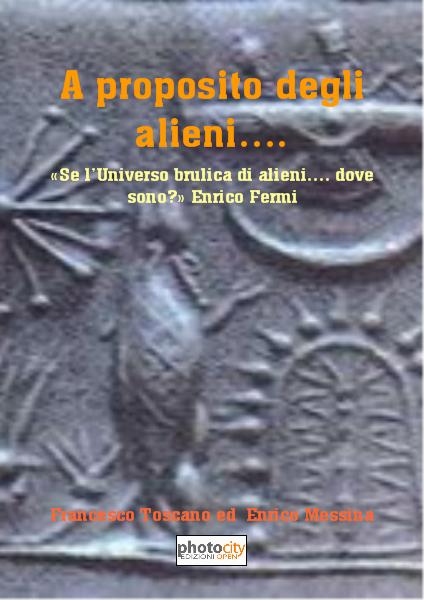
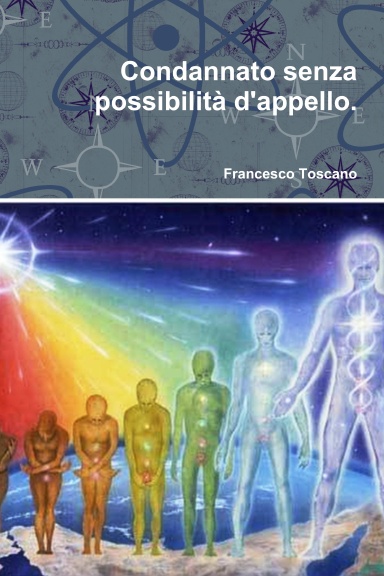
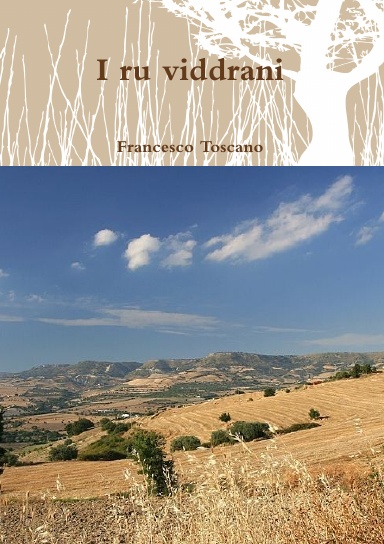
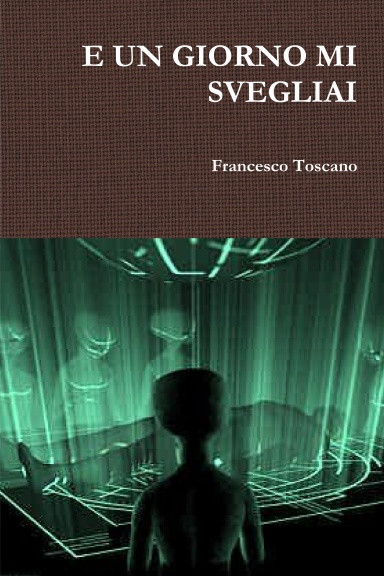

.png)




0 comments:
Posta un commento