 29 Gennaio 2008.
29 Gennaio 2008.Definito da Donald Garstang “il principale artista dello stucco in Europa” e da Giulio Carlo Argan “uno dei massimi scultori del Settecento”, Giacomo Serpotta (Palermo, 1656-1732) realizzò un’autentica rivoluzione stilistica e culturale, rinnovando la tecnica tradizionalmente povera dello stucco in arte ricercata e alla moda. Ebbe fama, successo e committenze dalle principali congregazioni e compagnie ecclesiastiche cittadine e siciliane: oggi i sontuosi apparati decorativi (suoi o di allievi membri della famiglia) sono presenti in una trentina fra oratori e chiese nella sola Palermo. Il suo “segreto” fu quello di aggiungere polvere di marmo alla calce e al gesso, fino ad allora normalmente usati per formare lo stucco: polvere di marmo che dava una inusitata patina di lucentezza alle figure. La difficoltà di questa tecnica, cioè la rapidità con cui doveva essere lavorato lo stucco prima che si asciugasse, richiedeva un artista particolarmente fantasioso nell’improvvisare dettagli nei volti, nei gesti e negli ornamenti. Accadde, così, che molte confraternite che, per motivi economici, non potevano permettersi il marmo, si rivolsero a Serpotta, il quale con lo stucco realizzava opere assai meno costose, ma dai risultati ugualmente brillanti. L’eccezionale tecnica di Serpotta si sposò al suo talento compositivo, all’esuberanza del gusto e alla capacità di organizzare spazio, immagini e forme nell’ambiente in cui doveva operare. Quel che continua ad essere sorprendente, infatti, dopo 350 anni, nell’opera di questo genio della plastica scultorea, è la sua qualità di magistrale regista di spettacoli d’incomparabile grazia, rispetto al contesto spaziale in cui sono poste le sculture, dove risulta stupefacente la loro orchestrazione plastica e fluttuante. Al punto che, forse, più che di decorazione, è più opportuno parlare di un raffinato teatro nel quale figure allegoriche, putti e “teatrini prospettici” possiedono una vitalità così intensa e morbida, da realizzare una dinamica ritmica quasi musicale. La vita. Poco si sa della sua vita, che non provenga da documenti riguardanti le opere. Nacque nel 1656 a Palermo, nel quartiere della Kalsa, da una famiglia di lapicidi e marmorari palermitani. Il padre Gaspare – autore di due gradevoli statue in Cattedrale – era un uomo difficile, amava i cavalli da corsa e nel 1656 rimase gravemente ferito in una rissa; fu poi arrestato e andò in galera, lasciando la famiglia in gravissime difficoltà economiche. Questa condizione di estrema povertà dei Serpotta e i loro legami di parentela con le principali famiglie artigiane della città fanno pensare che la formazione di Giacomo avvenne nelle botteghe locali, peraltro di eccellenti tradizioni. Certi suoi riferimenti al Barocco romano, più che dovuti ad una sua permanenza nella capitale (piuttosto dubbia), sono da ascrivere alla conoscenza di stampe coeve o a collaborazioni con artisti che a Roma avevano lavorato. Il primo incarico lo ebbe a Monreale, dove collaborò alla decorazione della chiesetta della Madonna dell’Itria. Ma il primo lavoro significativo lo fece nell’oratorio della compagnia della Carità in San Bartolomeo (1679), una delle più antiche di Palermo, distrutto nell’ultima guerra. Fu forse grazie a questo intervento che gli venne commissionata (1680) la statua di Carlo II di Spagna, fusa in bronzo a Messina e distrutta durante i moti del 1848. L’opera più antica che ci è pervenuta, invece, è costituita dai due altari del transetto della chiesa del Carmine, a Ballarò, con l’uso di gigantesche colonne tortili. Il primo capolavoro è l’apparato decorativo nell’oratorio del Rosario a Santa Cita (1685-1690), dove l’artista stuccatore diventa scultore a tutto tondo, padroneggiando sia i grandi spazi che i più piccoli dettagli; e dove si mescolano armoniosamente senso drammatico, sottigliezza psicologica e capacità comunicativa. Qui è importante la probabile collaborazione progettuale con Giacomo (o Paolo) Amato. Ma l’opera forse più equilibrata e solenne di Giacomo Serpotta è la decorazione per l’oratorio dei Santi Lorenzo e Francesco (1699-1706), dove la fusione tra lo stucco e i dipinti seicenteschi presenti nell’ambiente crea un’atmosfera da sacra rappresentazione barocca; un barocco non più grave e pesante, bensì giocoso e leggiadro. Le principali opere successive andranno verso una visione sempre più tendente al rococò: i modelli per i marmi scolpiti da Gioacchino Vitagliano a Casa Professa (primi ’700), gli stucchi nelle chiese di Sant’Agostino (1711), di San Francesco d’Assisi (1723) e di San Matteo (1728). Famiglia e allievi. Serpotta si circondò spesso di allievi e collaboratori, anche per gestire l’enorme quantità di commesse che riceveva. Alcune opere, così, seppure documentate a Giacomo, non sono a lui riferibili, se non nel disegno generale e in qualche parziale intervento. Tra questi collaboratori, che raggiunsero peraltro ottimi livelli di qualità, ci furono il fratello Giuseppe (Palermo, 1659-1719), autore degli stucchi dell’oratorio dei Falegnami; il figlio Procopio (Palermo o Monreale, 1679 - Caccamo 1755), considerato il vero erede del padre, cui si devono, fra l’altro, le decorazioni della chiesa dell’Assunta e degli oratori di Santa Caterina d’Alessandria e del Sabato a Casa Professa; e il nipote Giovan Maria Serpotta (notizie nella metà del ’700), figlio di Procopio. “Il progetto – sottolinea il sindaco Diego Cammarata – promuove la nostra città, ne mette in mostra un passato illustre, evidenziandone, nello stesso tempo, un presente fatto di cantieri aperti, di lavori per creare infrastrutture e sviluppo. I quattro itinerari serpottiani danno la possibilità ai turisti e anche agli stessi cittadini di conoscere un patrimonio prezioso; ma mostranno pure una città che ha fatto della riqualificazione e del recupero una delle sue priorità, che accende i riflettori sul suo cuore antico, con grande attenzione al decoro e all’arredo urbano”.












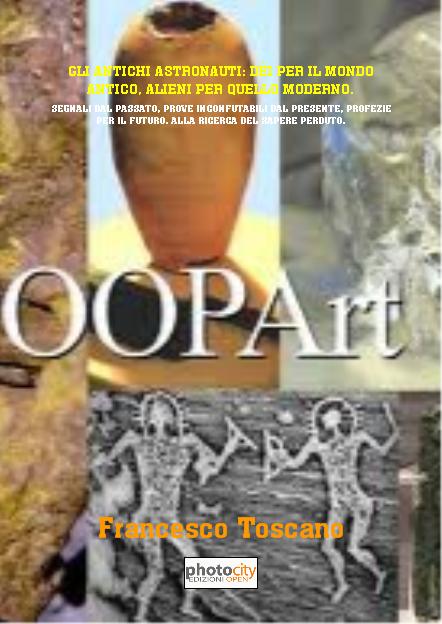
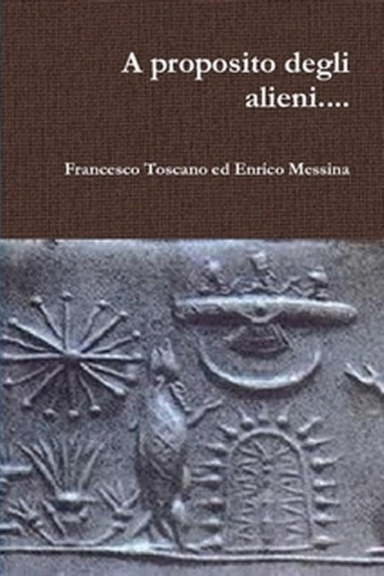
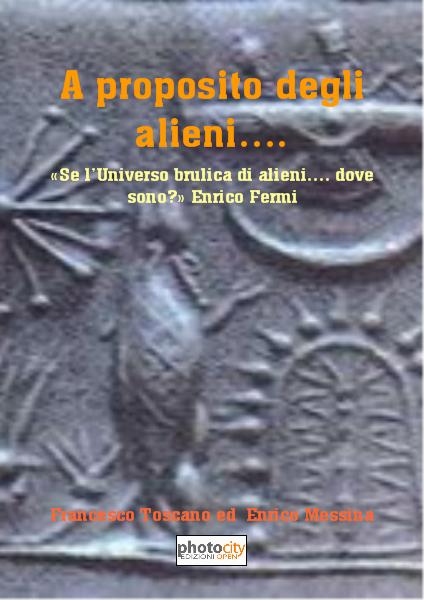
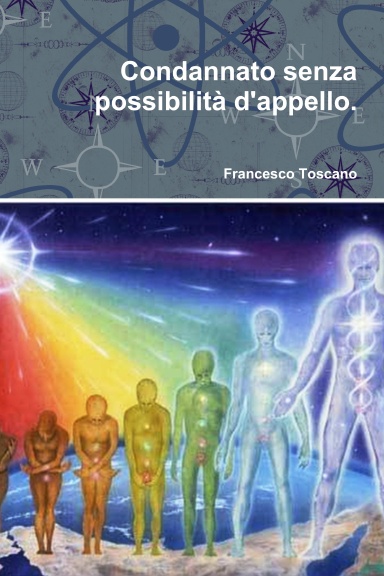
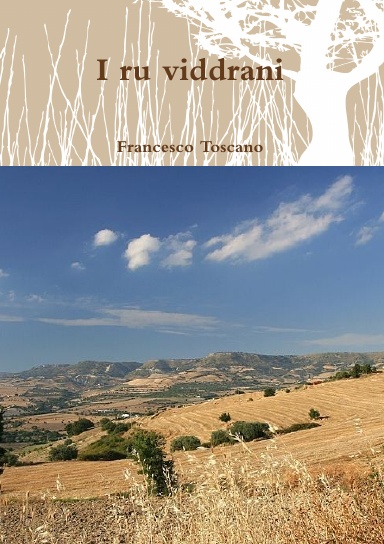
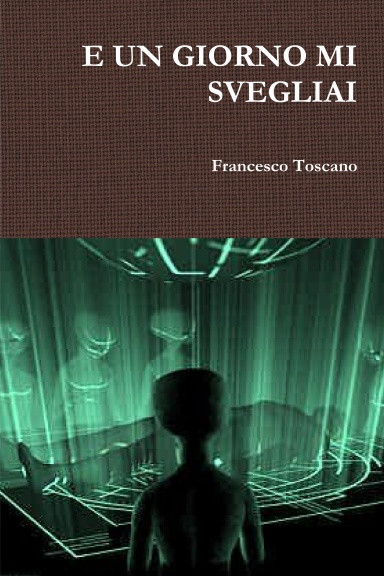

.png)




0 comments:
Posta un commento